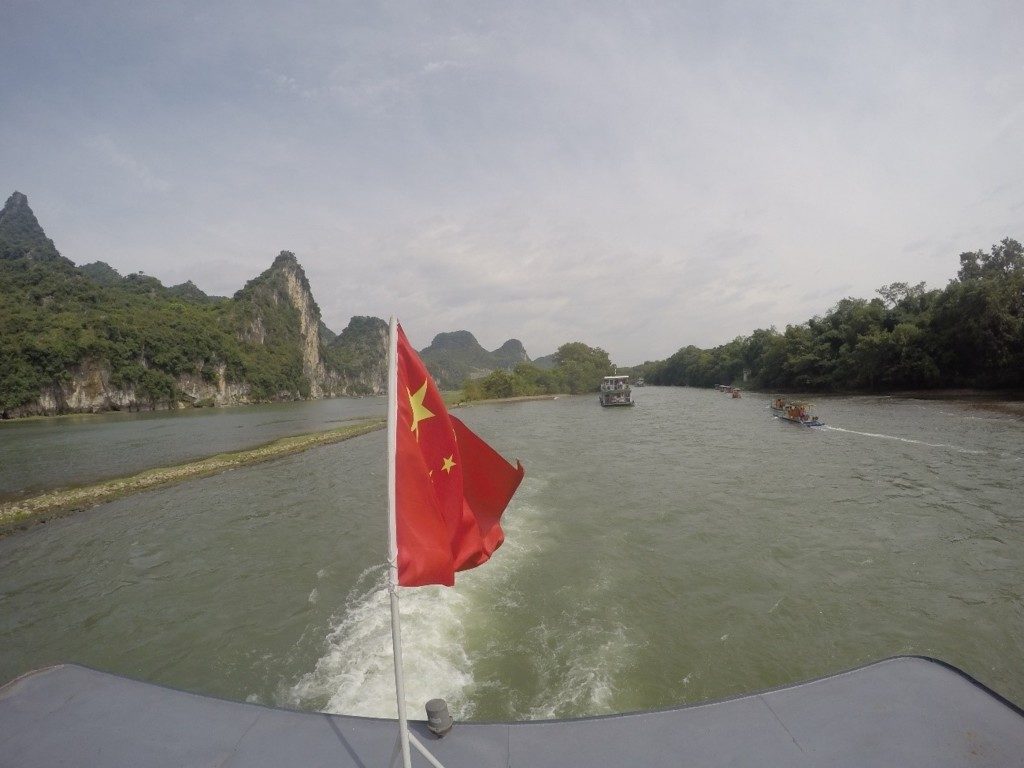La Repubblica Popolare Cinese, dopo aver superato la lunga fase di isolamento diplomatico, si presenta al giorno d’oggi come una grande potenza mondiale. Tuttavia, la Cina di Xi non si accontenta più del primato economico-commerciale (oramai riconosciutole da diversi anni), ma aspira a una ragguardevole espansione della propria sfera di influenza all’interno del quadrante dell’Asia-Pacifico. Ai fini della realizzazione di questo ambizioso progetto geopolitico, il governo di Pechino deve necessariamente fare i conti con Taiwan, dal momento che questo piccolo Stato de facto costituisce il pezzo mancante del grande mosaico cinese.
Dalla guerra civile alla proclamazione della Repubblica Popolare Cinese
Non si possono al giorno d’oggi comprendere le labili relazioni sino-taiwanesi se non si ha ben chiaro il contesto storico-sociale da cui queste traggono le loro origini.
L’evento che ha caratterizzato non solo la storia politica di questi due paesi, bensì la politica internazionale della prima metà del XX secolo, è senza ombra di dubbio quello che è passato alla storia con l’appellativo di “guerra civile cinese”. Con questa si fa riferimento al sanguinoso conflitto armato, di natura prettamente politico-ideologica, che scoppiò nel 1927 tra il Partito Nazionalista Cinese (Kuomintang) e il Partito Comunista Cinese (PCC). La guerra si protrasse, a fasi alterne, sino al 1949, anno dell’emblematica proclamazione in piazza Tienanmen della Repubblica Popolare Cinese. Da allora, la comunità internazionale non solo si è trovata dinanzi a due antinomiche Cine (una originaria di stampo nazionalista, l’altra appena nata di ideologia comunista), ma si è vista costretta, negli anni Settanta, a scegliere di intraprendere relazioni diplomatiche con una sola di queste, escludendo di conseguenza l’altra. Ma facciamo ora un passo indietro, posizionando la lente d’ingrandimento sulle origini del conflitto.
La dicotomia tra KMT e PCC (fondato il 1º luglio 1921 a Shanghai) trova le sue origini già nel lontano 1927, quando l’ala sinistra del primo, congiuntamente al secondo (guidato allora da Chen Duxiu), decise di spostare la sede del governo nazionalista da Canton a Wuhan. Fu allora che, il 12 aprile 1927, il leader del KMT Chiang Kai-shek portò avanti una durissima repressione nei confronti dei comunisti del PCC e degli appartenenti alla “fazione rossa” del KMT. Poco dopo esser stato espulso dal KMT per le sue ignobili azioni repressive, Chiang Kai-shek non solo formò (coadiuvato dall’ala destra del Kuomintang) un nuovo governo nazionalista con base a Nanchino, ma in breve tempo riuscì a espellere tutta l’ala comunista del KMT dalla sua roccaforte di Wuhan, ritrovandosi in questo modo unico leader indiscusso alla guida del Partito Nazionalista Cinese.
Il periodo storico che va dal 1927 al 1937, conosciuto anche come il “decennio di Nanchino”, fu un periodo di estrema stabilità politica, nel quale il “generalissimo” Chiang Kai-shek fece di questa maestosa città la capitale della Repubblica di Cina (Nanchino in mandarino significa “capitale del Sud”). Non bisogna, tuttavia, commettere l’errore di immaginare il decennio di Nanchino come un periodo di florida democrazia, dal momento che questa era completamente inesistente. L’unico partito politico ammesso alla competizione elettorale era infatti il KMT e la società era fondata su un vero e proprio “culto del generale”.
Mentre a Nanchino si decidevano le sorti della Repubblica di Cina, a seguito della grande sconfitta riportata nel 1927 contro il KMT, il PCC abbandonò in quegli anni il campo di battaglia, rifugiandosi nelle remote zone collinari, per poi tentare nuovamente un colpo di Stato militare ai fini di ribaltare il regime dittatoriale di Chiang Kai-shek. Tuttavia, i tentativi di sollevazione a Nanchang (agosto 1927), Changsha, Shantou e Canton non raggiunsero gli esiti sperati, così come si dimostrò un vero fallimento anche quella passata alla storia come la “sollevazione del raccolto di autunno” del settembre 1927, guidata direttamente da Mao Zedong. Sedati i tentativi rivoluzionari da parte degli insorti comunisti, nel giugno 1928 Chiang Kai-shek prese il controllo di Pechino (che era ancora in mano ai signori della guerra), completando così la riunificazione dell’intero territorio cinese. Ottenne infine il riconoscimento della sovranità, da parte dell’intera comunità internazionale, di un unico legittimo governo cinese, quello nazionalista di Nanchino.
Posteriormente ai fallimentari tentativi insurrezionali del 1927, il PCC di Mao Zedong cambiò strategia, cessando di esistere come “partito operaio” e divenendo piuttosto un apparato politico-militare estremamente burocratizzato. Nel 1928 il PCC, dopo aver fondato la sua “armata rossa” con i rispettivi 10.000 uomini, iniziò a conquistare qualche zona rurale dell’entroterra cinese (Hunan, Jiangxi), fino a costituire, il 7 novembre 1931, una Repubblica sovietica cinese, avente Mao come Presidente. Tuttavia, tra il 1931 e il 1934, gli attacchi militari del regime nazionalista di Chiang Kai-shek contro queste roccaforti comuniste si fecero più intensi e obbligarono i comunisti a evacuare le zone occupate, provocando quella che è passata alla storia come “la lunga marcia”. Questa consistette, da un punto di vista meramente strategico-militare, in uno spostamento delle truppe comuniste a 6.000 chilometri a nord e fu giustificata da Mao non come ritirata militare delle sue truppe dagli attacchi dell’esercito del regime nazionalista, bensì come un’avanzata verso il nemico nipponico, che nel frattempo (1931) aveva invaso la regione della Manciuria. Dalla “lunga marcia”, al di là delle varie interpretazioni possibili, se ne può ricavare solo una grande conseguenza politica: Mao Zedong si affermò come indiscusso leader del Partito Comunista Cinese.
La guerra civile subì una brusca interruzione del 1937. Nel luglio di quell’anno ebbe infatti inizio, con l’incidente del ponte di Marco Polo, il secondo conflitto sino-nipponico, durato sino al 1945. In questo lasso temporale, i due leader belligeranti Mao Zedong e Chiang Kai-shek misero da parte il loro astio e, attraverso l’istituzione di un fronte unito, combatterono congiuntamente per otto lunghi anni l’occupante esercito giapponese.
Dopo la sanguinosa parentesi del secondo conflitto sino-nipponico, la guerra tra il KMT e il PCC riprese nel 1946. A differenza di Mao, Chiang Kai-shek usciva tremendamente indebolito dal conflitto, dovendo gestire un paese con un’inflazione spropositata e un’economia rovinata dai cospicui costi bellici erogati durante gli otto anni di conflitto armato. Inoltre, il governo di Nanchino era caduto in forte discredito agli occhi della popolazione e persino gli ufficiali dell’esercito nazionalista avevano voltato le spalle al “generalissimo”, entrando ufficialmente nelle fila dell’esercito comunista di Mao. Fu così che Mao Zedong, dopo aver riportato una vittoria decisiva in Manciuria con la campagna di Liaosen, approfittò della profonda crisi del regime nazionalista e, dopo aver riportato una seconda e terza vittoria nelle rispettive campagne di Huaihuai (fine 1948-inizio 1949) e Pechino (31 gennaio 1949), proclamò a piazza Tienanmen la Repubblica Popolare Cinese (1º ottobre 1949).
Due antinomiche Cine
La costante e inarrestabile avanzata comunista fece sì che Chiang Kai-shek, dopo aver lasciato Chongqing nel novembre 1949 (ultima capitale del regime nazionalista, dal momento che Nanchino era stata occupata dall’esercito di Mao in aprile), abbandonasse la Cina continentale e si rifugiasse, scortato dalla Settima flotta statunitense, sull’isola di Formosa. Una volta giunti a Taiwan, i nazionalisti trovarono un’isola di sei milioni di persone, isola che dal 1895 al 1945 era stata posta, per motivi coloniali, sotto la sfera di influenza giapponese e che ora, a distanza di così pochi anni, si trovava nuovamente ad essere oggetto di un’invasione, questa volta da parte della “vecchia madrepatria”. Nel dicembre del 1949, Chiang Kai-shek proclamò provvisoriamente Taipei capitale della Repubblica di Cina, dal momento che lo scopo del generale, al tempo, era ancora quello di riottenere il controllo non solo sulla vecchia capitale di Nanchino, bensì sull’intera Cina continentale.
A seguito della ritirata di Chiang Kai-shek sull’isola di Formosa, le relazioni tra la Cina e il neo-proclamato Stato de facto di Taiwan furono in quegli anni la diretta conseguenza dell’astio politico venutosi a creare tra il PCC e il KMT durante la guerra civile. Da un lato troviamo una Repubblica Popolare Cinese forte (avendo ormai conquistato l’intero territorio continentale), che tuttavia non gode di alcun riconoscimento internazionale; dall’altro abbiamo invece il vecchio regime nazionalista (riconosciuto dall’intera comunità internazionale sino agli anni Settanta, con tanto di seggio permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite) costretto a rifugiarsi su un’isola del Pacifico, pronto (per lo meno ideologicamente) alla riconquista della Cina continentale. Come meticolosamente descrive Ricardo Paseyro all’interno della sua opera Taïwan, clé du Pacifique:
La lotta per il potere in Cina oppose allora e oppone tutt’oggi non solo due partiti politici ma due concezioni antinomiche della vita e della società.
Taiwan risulta essere al giorno d’oggi uno Stato de facto che, nonostante le sue dimensioni, il suo marginale peso militare (in rapporto a quello di Pechino) e il suo grande isolamento diplomatico, riesce non solo a tenere testa al governo di Xi Jinping, ma anche a mantenere completamente intatto il proprio status quo, nonché la sua forte aspirazione indipendentistica.
Perché il governo di Xi Jinping vuole riannettere Taiwan
La Repubblica Popolare Cinese, pur ritrovandosi separata dall’isola di Formosa da quasi settant’anni, non ha ancora rinunciato all’aspirazione di riannettere formalmente (quindi da un punto di vista politico) la “provincia ribelle” al territorio continentale, obiettivo sempre più tangibile all’interno della visione politica del Presidente Xi Jinping. La riannessione di Taiwan rientra infatti, per varie ragioni che andremo ora a esporre, tra le priorità di Xi.
La prima ragione è di natura prettamente geostrategica. Annettere l’isola di Formosa alla Cina continentale vuol dire offrire per la prima volta alla Cina uno sbocco diretto sull’oceano Pacifico, togliendone il primato agli Stati Uniti d’America e al Giappone. Inoltre, Taiwan domina due aree marittime di importanza altamente strategica: lo stretto di Formosa e quello di Luzon; questi due stretti rappresentano il fulcro delle crescenti mire della Cina. Il Pacifico costituirebbe dunque la chiave di questo ambizioso progetto egemonico.
La seconda ragione per la quale il governo di Xi sarebbe così interessato alla riannessione formale di Taiwan affonda le proprie radici nella storia. Lo smacco subito da Mao Zedong nelle tre crisi dello stretto di Formosa ha prodotto una ferita ancora aperta e tangibile all’interno della Cina continentale, che mai come ora nutre un grande spirito revanscista. Xi manifesta dunque la volontà politica di rimediare a quello smacco storico, visto e considerato che, qualora la Cina di Xi riuscisse negli anni venturi a riannettere Taiwan, il Presidente cinese porterebbe a termine la tanto grande quanto incompiuta impresa di Mao. Questa posizione è accuratamente avanzata dall’autore cinese Yuwen (Limes, volume 11/2018):
Il leader cinese è un nazionalista; l’unificazione fa parte del sogno cinese del sentimento nazionale, come lui li intende. Solo prendendo Taiwan e unificando le due sponde, ‘impresa immortale’ nella narrazione storica del partito, Xi supererebbe Mao.
La terza e ultima ragione del “grande sogno di Xi” ci riporta a una dimensione prettamente politica. Il Partito Comunista Cinese (di cui Xi Jinping è anche Segretario) è stato protagonista, negli ultimi anni, di innumerevoli scandali, legati per lo più alla grande corruzione interna ad esso; la riannessione di Taiwan non solo “insabbierebbe” i vari scandali politici dei vertici del PCC, ma garantirebbe a quest’ultimo un ampio margine di consenso da parte dell’intera società civile. La visione politica di Xi Jinping, inoltre, aborrendo le spinte centrifughe all’interno del vasto territorio cinese (basti pensare all’attuale situazione della regione dello Xinjiang), mira a una “rinascita nazionale cinese”, un ambizioso progetto di cui la “ripresa di Taiwan” costituisce un tassello fondamentale. Se Xi riuscisse a prendere Taiwan, non solo diverrebbe il grande eroe nazionale, ma questa impresa titanica gli garantirebbe un’assicurazione sulla vita dopo il suo ritiro dalla scena politica cinese.
La riannessione di Taiwan, tuttavia, non avverrà nel breve periodo e tantomeno mediante l’uso della forza. La Cina è infatti altamente consapevole del fatto che dichiarare guerra a Taiwan, e poi riconquistarsela, vorrebbe dire anche gestirne le conseguenze. Dominare un territorio che è stato conquistato con la forza è molto diverso che dominare un territorio che è stato ammesso pacificamente. Il governo di Pechino a guida Xi Jinping cercherà, come sta già facendo da diversi anni, di fagocitare Taiwan sempre di più all’interno del proprio sistema economico, per poi eventualmente offrire a questo piccolo paese del Pacifico lo status di Regione Amministrativa Speciale, al pari di Hong Kong.
Sergio Tagliata per Policlic.it